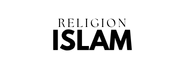Caro fratello/cara sorella,
In termini di diritto islamico, alla pratica commerciale che lei ha sollevato come problema
“Vendita di Îne”
viene definito così. Secondo la definizione più comune
îne,
“la vendita di un bene a un certo prezzo con un pagamento dilazionato, con la successiva riacquistazione a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita”
Lo stesso vale se la transazione viene effettuata tramite un intermediario. Questo tipo di procedura, comunemente utilizzata per aggirare il divieto di usura e ottenere finanziamenti a termine, rientra nella categoria della vendita a termine.
Vendita di îne
trasforma una normale compravendita in un’operazione strettamente correlata agli interessi, motivo per cui nella nostra cultura giuridica l’argomento viene trattato in questo contesto.
Nell’esaminare gli argomenti nella giurisprudenza islamica,
le intenzioni e i propositi delle persone
piuttosto che un riflesso esteriore del comportamento
Immagini oggettive
È noto che il principio fondamentale è quello di dare priorità alla legge, e che le procedure legali sono vincolate, nella misura del possibile, a regole oggettive e chiare. Ciò perché la creazione di ordine e stabilità nella vita giuridica, e la protezione dei diritti dei terzi, dipendono in parte da questo.
Tuttavia, nella dottrina giuridica islamica non sono state trascurate le intenzioni e le motivazioni alla base delle azioni; almeno nei giudizi, si è insistito sulla distinzione tra giudizio religioso e giudizio civile, sottolineando che la conformità formale di un atto giuridico alla legge potrebbe non essere sufficiente per esonerare le persone dalla responsabilità di fronte a Dio, poiché Dio considera importanti anche la volontà e i pensieri interiori delle persone. È necessario valutare le discussioni sulla liceità o meno della vendita di beni in pegno alla luce di queste informazioni.
Vendita di vacche
Nel diritto islamico, si discute se nei contratti debbano essere considerati essenziali i requisiti formali o la reale intenzione e il fine delle parti, e se l’intenzione e il proposito dei contraenti abbiano un impatto sul contratto, ovvero se sia lecito raggiungere un risultato proibito attraverso mezzi leciti, cioè
trucco lecito (o astuzia lecita)
sono stati affrontati e discussi aspetti quali la loro liceità o meno.
Sebbene i giuristi hanafiti, in linea di principio, riconoscessero che l’intenzione e il proposito non influenzano la validità del contratto, ricorressero frequentemente alla hīla-i šar’iyya (una forma di astuzia legale) e considerassero sufficiente, in linea di principio, la presenza impeccabile dell’elemento essenziale del contratto nelle relazioni contrattuali, essi, tenendo conto di una dichiarazione di Aisha (ra) su questo argomento, hanno sostenuto che la vendita tramite ‘īn (un tipo di contratto di vendita) non è consentita ed è invalida.
La base giuridica degli studiosi hanafiti su questo argomento è il seguente racconto tramandato da Aisha (ra):
“Una donna si avvicinò ad Aisha (ra) e le disse:
“Avevo una schiava. L’ho venduta a Zayd ibn Arqam a 800 dinari a credito. Poi ho riacquistato la stessa schiava da Zayd ibn Arqam a 600 dinari in contanti, pagandoli subito. Ora lui mi deve 800 dinari.”
disse. Aisha,
“Che cattiva vendita hai fatto e che cattivo acquisto hai fatto! Vai a comunicarlo a Zayd; Dio ha annullato la sua partecipazione alla Jihad al fianco del Profeta. Ma se si pente, è un’altra cosa.”
rispose. A quel punto la donna disse ad Aisha:
“Potrei ritirare il mio capitale e restituire la parte in più?”
Chiese. E Aisha rispose:
“Chiunque riceva un monito dal suo Signore e si penta, il suo passato sarà per lui un bene.”
Recitò il versetto (2:275) della Surah Al-Baqarah.” (Abdurrazzak as-San’ani, al-Musannaf, VIII, 184-185; Shawkani, Nayl al-Awtar, V, 206).
L’utilizzo delle parole di Aisha (ra) a sostegno di questa opinione si spiega così: la dura affermazione di Aisha (ra) riguardo a Zayd ibn Arqam, che aveva stipulato un contratto di vendita simile, ovvero che le sue azioni di devozione compiute fino a quel momento sarebbero state vane a causa di un comportamento diverso dall’apostasia, non è una questione che possa essere conosciuta attraverso la ragione e il giudizio. Quindi Aisha (ra) deve averlo sentito dal Profeta (pace e benedizioni su di lui). Ciò dimostra che il contratto stipulato da Zayd era invalido. Infatti, un contratto invalido è un peccato. D’altra parte, Aisha (ra) ha giudicato questo contratto…
“una cattiva vendita e un cattivo acquisto”
L’ha definita come tale. Questa caratteristica è adatta a un contratto nullo.
Sebbene la principale giustificazione degli studiosi di diritto hanafita in merito sia la dichiarazione di Aisha (ra), alcuni hanafiti non sono d’accordo con tale dottrina.
“sospetto di riba’”
Hanno indicato la presenza di questo elemento come motivo per cui non è lecito, spiegando il concetto nel seguente modo: il prezzo (semen) nel secondo contratto è in realtà il corrispettivo del prezzo del primo contratto. Pertanto, in un contratto di vendita, che è un contratto di scambio (che permette lo scambio di prestazioni reciproche), non esiste alcun corrispettivo per la parte in cui il primo prezzo supera il secondo, il che è in linea con la definizione di riba. Sebbene questa riba sia stabilita dall’insieme dei due contratti e, con uno dei contratti, sia stabilita non la riba stessa ma solo il sospetto di riba, in questi casi il “sospetto” è considerato come “verità”.
Inoltre, viene riportato un altro hadith riguardante l’ine: Ibn Umar,
“Che tempi sono questi! Un tempo nessuno di noi pensava che i propri dinari e i propri dirham fossero più meritevoli di quelli del fratello musulmano. Ora invece, i dinari e i dirham sono diventati più cari a ciascuno di noi del fratello musulmano.”
e dopo aver detto questo, ha narrato che il Profeta (pace e benedizioni su di lui) disse:
“Se sarete avari riguardo al dirham e al dinar, se farete i vostri affari con mezzi illeciti, se vi aggrapperete alla coda delle mucche e vi limiterete all’agricoltura, e se abbandonerete la jihad, Allah vi infliggerà una umiliazione tale che non la rimuoverà da voi finché non vi sarete convertiti alla vostra religione.”
(Abu Dawud, “Biyû’”, 56; Musnad, II, 84).
Secondo i giuristi hanafiti, questo contratto è considerato nullo non a causa di una regola consolidata (qiyas), ma a causa di una dichiarazione (hadith) di Aisha (ra), e nella dichiarazione di Aisha (ra) si parla solo di…
“Acquistare a un prezzo inferiore a quello di vendita”
Sostengono che, secondo quanto affermato, sia lecito per una persona riacquistare un bene che ha venduto a un prezzo superiore a quello di vendita, prima ancora che il pagamento sia stato effettuato. Anche nella scuola di pensiero Hanafita, non si vede alcun problema nel fatto che il venditore riacquisti lo stesso bene a un prezzo più alto dopo che il compratore ha pagato il prezzo di acquisto. Questo perché in questo caso non si verifica la condizione di equivalenza tra i due prezzi nei due contratti.
I malichiti affrontano il problema
barriera vegetale
Hanno considerato il principio di “sbarrare le strade al male”, ovvero il principio di chiudere le vie che conducono al male, e, pur essendo lecito in apparenza, non hanno ritenuto lecito il contratto di vendita di una mucca perché porta all’usura. Ibn al-Qayyim, tra gli Hanbaliti, ha affrontato il tema dal punto di vista dell’inganno, sostenendo che le parti nascondono le loro intenzioni illecite sotto l’apparenza di un contratto valido e affermando che un tale contratto non può essere lecito.
Non sfugge un sottile distinguo tra l’approccio dei Malichiti e quello degli Hanbaliti. Mentre i Malichiti proibiscono la vendita di una mucca, poiché potrebbe essere usata come mezzo per ricorrere al ribâ (usura) proibita e le parti potrebbero essere sospettate di questo, gli Hanbaliti, in particolare Ibn al-Qayyim, considerano quasi certo che le parti abbiano l’intenzione di effettuare un’operazione ad interesse e usino la vendita come scusa.
Nelle scuole di pensiero che non ammettono la vendita di una bestia da soma, si è discusso anche su quale dei due contratti di vendita sia invalido e debba essere annullato. Mentre nella scuola di pensiero Hanafita si afferma che è più probabile che il secondo contratto sia invalido, nelle scuole di pensiero Malikita e Hanbalita la maggior parte degli studiosi ritiene che entrambi i contratti siano invalidi e debbano essere annullati.
Al contrario, lo Šāfi’ī, partendo dal presupposto che il contratto possedesse i requisiti di validità e che non fossero presenti condizioni che lo rendessero nullo, ha affermato che la vendita di un raccolto non ancora maturato fosse valida. Lo Šāfi’ī non ha tenuto conto delle intenzioni delle parti, ritenendo sufficiente che il contratto avesse i requisiti formali. In questa questione, si nota chiaramente la tendenza dello Šāfi’ī a considerare solo l’intenzione manifestata, senza dare peso all’intenzione soggettiva. Lo Šāfi’ī non considera nemmeno attendibile l’hadīth attribuito ad Aisha (ra) che gli Hanafiti usano come giustificazione. Inoltre, gli studiosi di diritto Šāfi’ī hanno citato un altro hadīth, la cui pertinenza all’argomento non è né chiara né completa, a sostegno della validità della vendita di un raccolto non ancora maturato (Bukhārī, “Büyû’”, 89; “Vekāle”, 3; Muslim, “Müsākat”, 18; al-Muwatta’, “Büyû’”, 20, 21).
Sia il racconto di Aisha (ra), sia le parole di Ibn Umar, se le narrazioni sono considerate autentiche, dimostrano che in quel periodo esistevano compravendite tramite il sistema di “îna”. Tuttavia, si dovrebbe considerare che non avevano l’intenzione di stipulare un contratto fittizio, ma lo facevano in base alle necessità e alle circostanze. È possibile che l’evento si sia svolto in questo modo:
Zayd acquistò una schiava da quella donna a credito, ma dopo un po’ ebbe bisogno di denaro per altro e le propose di rivenderle la schiava a prezzo inferiore e contanti, e lei potrebbe aver accettato. Se non avesse accettato, Zayd avrebbe dovuto vendere la schiava a qualcun altro. Non c’è dubbio sulla legittimità del contratto stipulato in questo contesto. Quindi, si può dire che, se non è subordinato a una condizione preesistente, non c’è motivo per cui questa operazione non sia legittima. Tuttavia, se questa operazione viene diffusa e istituzionalizzata allo scopo di mascherare gli interessi, non è possibile che sia considerata lecità dalle altre tre scuole di pensiero. Anzi, in questo caso, l’intenzione di ottenere interessi sarebbe ormai palese, e quindi questa operazione perderebbe la sua legittimità anche secondo la scuola di pensiero Shafi’i.
Vendita tramite Îne,
Sebbene questo sia l’uso comune e tecnico in termini di terminologia, alcuni giuristi malikitici hanno considerato anche alcune vendite simili come comprese nella vendita di îna. Ibn Rushd ha suddiviso l’îna in tre categorie: lecito, sconsigliato e proibito.
a) Il lecito prosegue così:
“A si reca da B e gli dice: ‘Se hai questo bene, lo comprerò’. B risponde che al momento non lo possiede, ma poi informa A che ha acquistato il bene richiesto e che può venderglielo, se lo desidera, a pagamento immediato o a termine. Questa operazione è lecita. Le parti non hanno alcun obbligo reciproco. A può acquistare il bene se lo desidera, altrimenti no.”
b) La forma del Mekruh è la seguente:
A si reca da B e gli chiede di acquistare un certo bene per lui, dicendogli che avrebbe poi riacquistato il bene da lui con un certo margine di profitto, senza aver concordato in precedenza il tasso di profitto. Questa operazione è considerata mekruh (desiderabile evitare).
c) Se è proibito,
Si tratta di concordare in anticipo il margine di profitto per la stessa operazione. Ad esempio: A a B
“Acquista quel prodotto a 100 lire in contanti, e io lo acquisterò da te a 120 lire a credito.”
e il contratto viene così stipulato. Questa operazione, che non viene menzionata nelle altre scuole di diritto islamico, non è considerata lecità dai giuristi malikiti. L’ine di cui parlano i giuristi malikiti, con questo contenuto, è simile al sistema oggi chiamato “leasing”.
Nell’ambito di Îne, viene valutata anche la seguente operazione:
Una persona bisognosa chiede un prestito a qualcuno in una situazione migliore. Ma quest’ultimo non vuole dare in prestito senza ottenere un vantaggio e dice:
“Non posso farti un prestito. Ma posso venderti questa merce, che ha un valore di mercato di 100 lire, a 120 lire a credito, e tu poi la rivenderai a 100 lire.”
La transazione si perfeziona quando colui che richiede il prestito accetta. (Ibn Abidin, Reddu’l-Muhtar, V, 273). Tuttavia, questo tipo di transazione nella terminologia…
“tevarruk”
Questa pratica è definita come (vedi Ibn Kayyim, İ’lâmü’l-muvakkı’în, III, 170, 200) ed è generalmente considerata lecità dalle scuole di pensiero diverse da quella Hanbalita. Tuttavia, poiché questa pratica consiste nello approfittare della situazione di difficoltà di una persona, è considerata moralmente disapprovabile.
Oltre a questi approcci giuridici, esiste anche un aspetto religioso-morale della questione, che consiste, come chiaramente evidenziato nell’hadith di Ibn Umar, nel dovere dei musulmani di cercare di realizzare la mutualità sociale tra loro senza alcun intento di profitto materiale. Pertanto, non va dimenticato che il modo naturale per prevenire il ricorso a vie tortuose che non si possono giustificare dal punto di vista religioso, è quello di creare e sviluppare istituzioni e strutture economiche che consentano a chi ne ha bisogno nella società di accedere a prestiti senza interessi; e che questo è un dovere ineludibile per tutti i musulmani, in particolare per i ricchi.
Con saluti e preghiere…
L’Islam attraverso le domande