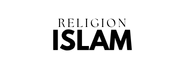– Su quali versetti coranici e hadit si basa l’affermazione che i precetti dell’Islam possano variare a seconda delle circostanze del tempo?
Caro fratello/cara sorella,
Contenuto nella Mecelle
“Non si può negare che con il mutare dei tempi, mutino anche le leggi.”
,
cioè
“È innegabile che, con il passare del tempo, anche alcune disposizioni normative cambino.”
Esiste un principio di questo tipo.
Questo principio si applica solo a questioni teoriche e a sentenze interpretative (relative a consuetudini, utilità pubblica, “isithsan, istishab, mesalih-i mursale” e simili). Modificare le disposizioni chiaramente stabilite nel Corano e nella Sunna è invece ignoranza e deviazione.
Anche in questo caso, un principio importante della legge islamica è il seguente:
“Non è possibile l’interpretazione (ijtihad) nei casi previsti esplicitamente dalla legge (Mevarid-i nass).”
cioè
“Non è possibile esprimere un’opinione personale (ijtihad) riguardo alle disposizioni legali chiare e esplicite del Corano e della Sunna.”
“Il novanta percento della Sharia – le necessarie e le fondamentali questioni religiose – sono colonne di diamante. Le questioni di interpretazione e di dissenso rappresentano il dieci percento. Non si affidano novanta colonne di diamante alla protezione di dieci d’oro.”
I libri e le interpretazioni teologiche devono essere come un cannocchiale o uno specchio per il Corano, non una semplice ombra o un sostituto!
…
(cfr. Hutbe-i Şamiye, p. 114)
La prova più evidente che le questioni di ijtihad possono cambiare nel tempo è che i quattro scolastici dell’Ahl-i Sunnat hanno stabilito diverse sentenze di diritto sacro con diverse interpretazioni di ijtihad.
Una raccolta di leggi islamiche.
Mecelle
Esaminando il commento all’articolo menzionato di ‘
quali sono le disposizioni che cambieranno con il mutare del tempo
si potranno trovare importanti chiarimenti in merito:
”
Le sentenze che cambiano con il passare del tempo, in realtà
sono disposizioni basate su consuetudini e usanze
Le sentenze basate sui testi sacri (corano e hadit) sono immutabili.
Poiché usanze e consuetudini possono manifestarsi anche sotto forma di credenze, interpretazioni e pratiche errate (non conformi alla religione), mentre ciò è impossibile per la legge religiosa. Ad esempio, accendere candele sulle tombe, diffondere calunnie (gossip), comprare e vendere oro e argento a quantità diverse a seconda che si tratti di pagamento anticipato o dilazionato (in questo senso, usura), vendere un bene nel suo contenitore e dedurre il peso approssimativo del contenitore… sono diventate usanze e consuetudini. Tuttavia, affermare che, poiché queste cose sono diventate usanze e il tempo è cambiato, anche i divieti (il fatto che siano proibite e illecite) cambiano, significa mettere a rischio la religione e la fede…
(cfr. 1/102)
In sintesi,
Le sentenze basate su consuetudini e usanze possono cambiare con il passare del tempo. Ciò che in un determinato tempo e luogo era consuetudine, usanza e pratica, può cambiare con il passare del tempo e essere sostituito da un’altra usanza e pratica. Se il fondamento di una interpretazione giuridica è costituito da usanze, consuetudini e interessi pubblici che cambiano, anche le sentenze basate su di esse cambiano.
– a causa del cambio di sede –
può cambiare.
Per informazioni e prove più dettagliate, vi consigliamo di leggere anche le seguenti dichiarazioni:
Diritto consuetudinario
Sono norme giuridiche basate sulla consuetudine e sulla prassi.
Gli studiosi di diritto islamico, nel cercare il fondamento e la legittimità del diritto consuetudinario, che è alla base del diritto consuetudinario, si sono basati su queste parole, nel Corano e nella Sunna,
“usanza”
e
“usanza”
hanno cercato testi che contenessero queste parole.
“Segui la via del perdono, ordina secondo la consuetudine e non dare retta agli ignoranti.”
(1) Il versetto che segue ne è un esempio. Tra i significati attribuiti al termine “urf” (usanza, consuetudine) in questo versetto dai commentari, quelli più vicini al significato tecnico sono “ma’rūf” (ciò che è noto, riconosciuto) e “cose buone e belle su cui concordano tutte le religioni e che non sono disapprovate dagli uomini”. (2) Nel Corano, questo concetto viene ripetuto e incoraggiato in 39 versetti.
“mârûf”
Dato che la maggior parte di questi versetti viene usata nel senso sopra descritto, il numero di versetti che supportano la consuetudine aumenta.
Se non si insiste sulla parola, è possibile trovare altri versetti nel Corano che riguardano usi e costumi. Questi versetti si riferiscono a abitudini, atteggiamenti e comportamenti che si estendono dal passato al presente e al futuro, nel senso di strade e comportamenti.
“sunen”
(3), nel senso di “tracce”
“âsâr”
nel senso di comunità legata a un sistema
“Ummah” (comunità dei credenti)
(4), nel senso di usanze delle generazioni passate
“Non è colpa dei nostri padri”
Sono state usate espressioni come:
Di fronte alle tradizioni menzionate in questi versetti, il Corano non adotta un atteggiamento di accettazione o rifiuto assoluto;
il vagliamento delle tradizioni attraverso il filtro della ragione e della rivelazione (wahi), l’accettazione delle tradizioni (usanze e costumi) che non sono contrarie alla rivelazione e che sono conformi alla ragione e alla natura umana,
mentre coloro che non si conformano sono invitati a lasciare:
“Quando viene detto loro di seguire ciò che Dio ha rivelato, essi rispondono: ‘No, seguiremo la via dei nostri padri’. Ma se i loro padri non erano illuminati e non avevano trovato la via giusta, perché dovrebbero seguirli?”
(5)
“…eppure, anche se vi ho portato una via migliore di quella dei vostri padri, voi mi abbandonerete e seguirete loro?”
(6)
“Affinché Allah vi spieghi ciò che vi è necessario, e vi faccia conoscere la storia di coloro che vi hanno preceduto.”
(alle loro buone tradizioni)
vuole anche per voi condonare i vostri peccati e condurvi alla rettitudine; Egli è dotto e saggio.”
(7)
Barba, baffi, circoncisione, pulizia, profumo gradevole, strisciare
come le usanze, le tradizioni innate
(usanze conformi alla natura umana)
Anche gli hadith che menzionano (8) il pudore, l’applicazione di profumi, l’uso del miswak e il matrimonio, qualificandoli come usanze, modi e tradizioni dei profeti precedenti (9), supportano l’ultimo versetto, spiegando anche le fonti tradizionali.
Raccontato per sostenere la Sunna come fonte di usanze e tradizioni.
“Ciò che i credenti considerano buono e bello è anche bello agli occhi di Dio, e ciò che i credenti considerano brutto e cattivo è anche brutto agli occhi di Dio.”
La frase nella forma indicata non è stata tramandata come hadith; tuttavia, il fatto che Ibn Mas’ud l’abbia detta (10) riflette, almeno, il punto di vista generale dell’epoca.
Il Profeta Maometto (pace e benedizioni su di lui),
il patto dei virtuosi
in merito a
“Ero presente alla stipula di un patto nella casa di Abdullah b. Cud’an, un patto che non cambierei per nessun altro al mondo; se fossi invitato a un patto simile anche dopo l’Islam, lo accetterei immediatamente.”
(11) è stato riferito che egli abbia detto. Questo hadith dimostra che l’Islam non rifiuta assolutamente le tradizioni, anche se provenienti dall’epoca della Jahiliyya, ma le sottopone a una selezione.
L’atteggiamento del Profeta Maometto (pace sia su di lui) nei confronti di molte disposizioni giuridiche esistenti anche prima dell’Islam, è tra i più importanti pilastri del diritto consuetudinario. Esaminando contratti e disposizioni come la vendita a termine (salam), il matrimonio, il divorzio, il prestito (qard), ecc., si comprenderà che tale atteggiamento non rappresenta una semplice trasposizione o imitazione, bensì una riforma e una scelta compiuta nell’ambito delle disposizioni rivoluzionarie e dei principi eterni dell’Islam.
L’atteggiamento del Profeta Maometto (pace sia su di lui) nei confronti delle usanze e delle tradizioni è continuato anche durante il periodo dei primi califfi, e in particolare durante l’epoca degli imam mujtahid, le usanze e le pratiche (amal) delle regioni in cui vivevano sono state introdotte come fonte giuridica, e questo sviluppo
“uso, pratica, consuetudine, costume”
ha dato origine alla necessità di definire e classificare la fonte del diritto, espressa con termini come questi.
Ricetta:
Irfan,
abilità e consuetudine derivano dalla stessa radice, e questa radice è…
“conoscere, riconoscere”
ha un significato.
Costo abituale
“İse” ha la stessa radice di “avdet” e “iâde”, e il significato fondamentale di queste parole è “ripetizione, ritorno allo stato precedente, formazione costante nello stesso modo”.
Gli studiosi del diritto che riconoscono che usanza e consuetudine sono equivalenti in termini di significato.
“Sono cose (eventi, stati e comportamenti) che le persone con salute mentale e fisica ritengono ragionevoli e che, ripetendosi da tempo, si sono radicate nell’animo.”
hanno fornito una descrizione di questo tipo.
Gli studiosi di diritto sostengono che la consuetudine, che deriva sia dalla ragione che dalla volontà, e che comprende eventi, situazioni e comportamenti sia individuali che collettivi, sia essa basata su altre fonti, è più ampia del costume in termini di concetto, e quindi affermano che esiste una differenza tra i due termini. Essi hanno definito il costume come “la consuetudine che si manifesta nella società, verbalmente o con azioni”.
Di conseguenza, la consuetudine costituisce una forma di usanza e si basa sulla ragione e sulla volontà. Non vi è alcuna differenza tra la consuetudine menzionata come fonte giuridica e la consuetudine definita sopra; per questo motivo, il Mecelle, nell’articolo 36,
“L’usanza è un criterio decisivo; cioè, per stabilire una disposizione religiosa, si fa riferimento all’usanza e alla consuetudine come arbitro.”
citando tale articolo, ha inteso questi due termini come sinonimi.
Sezioni:
Usanze e consuetudini sono suddivise in due categorie distinte, una in base a cosa siano e l’altra in base alla loro diffusione. Nella prima categoria, la consuetudine,
“usanza verbale (usanza dichiarata)” e “usanza pratica (usanza di fatto)”
è suddiviso in due parti.
La consuetudine linguistica si forma attraverso l’uso di determinate parole e espressioni, al di fuori del loro significato letterale, o in uno dei loro significati letterali. Una volta pronunciata la parola, questo significato è compreso senza bisogno di ulteriori indizi; ad esempio, in passato la parola “dirhem” era usata per indicare la moneta in circolazione nel paese. La parola, in realtà, significa moneta d’argento e unità di peso per l’argento, ma quando si diceva “dirhem”, tutti intendevano il primo significato, e le operazioni giuridiche venivano condotte di conseguenza.
La consuetudine pratica si forma quando una società trasforma un determinato comportamento e una pratica in un’abitudine; il modo di pagare l’affitto di case e negozi, il pagamento di una parte della dote anticipata e di una parte successiva a determinate condizioni, la consegna di alcuni beni acquistati presso la casa o il negozio dell’acquirente, sono alcuni esempi di consuetudine pratica.
L’usanza è valida in tutti i tempi e luoghi relativi a un determinato ordinamento giuridico, oppure ovunque in un determinato periodo di tempo.
(diffuso) invece è umumî (âmm)
, se valido per determinate aree e specializzazioni
privato (hâss)
viene denominato. Mentre la consuetudine e l’usanza generali sono considerate una fonte giuridica, equiparate all’egregio consenso, la consuetudine e l’usanza particolari sono state oggetto di discussione a questo riguardo. L’articolo 36 della Mecelle…
“…sia in generale che in particolare”
ha optato per l’interpretazione che considera valide entrambe le forme di consuetudine, pur specificando tale condizione. Il famoso giurista Ibn Abidin, nel suo trattato dedicato alla consuetudine e alle usanze, dopo aver osservato che l’opinione secondo cui anche la consuetudine particolare è una fonte di diritto appartiene alla scuola di Belh degli Hanafiti, ha fornito numerosi esempi.(12)
Condizioni:
Affinché la mestruazione, in tutte le sue forme, sia considerata valida e possa svolgere le funzioni che verranno menzionate in seguito, sono stati proposti alcuni requisiti:
a) Essere applicabile a tutti o alla maggior parte degli eventi e delle azioni pertinenti.
Nell’articolo 40 del Mecelle
“L’usanza è valida solo se è consolidata o prevalente.”
, nell’articolo 41
“La reputazione è più spesso diffusa che rara.”
ha codificato queste condizioni con le sue regole. Il fatto che oggi non si restituisca al venditore l’imballaggio dell’oggetto acquistato, né i contenitori di carta o nylon, è un esempio di usanza (muttarit) applicata in ogni contratto, mentre il fatto che una parte della dote sia pagata anticipatamente e una parte sia dilazionata è un esempio di “gâlib”, in quanto è la prassi più diffusa nella maggior parte dei contratti di matrimonio.
b) Essere in vita al momento dell’evento giuridico e dell’atto di disposizione in questione.
Non è valida una consuetudine che, pur esistendo in passato o in futuro, non sia vigente al momento. In un paese in cui in precedenza si utilizzava il calendario lunare, ma tale consuetudine è stata modificata, le date e i calendari menzionati nei contratti sono considerati solari; il calendario precedente non è più valido.
c) Non devono esserci dichiarazioni contrarie alle usanze.
L’usanza generalmente completa gli aspetti non chiariti o non menzionati nelle disposizioni giuridiche; questi sono considerati menzionati per implicazione dell’usanza.
Tuttavia, poiché in presenza di una dichiarazione esplicita non si tiene conto di una deduzione contraria (13), in presenza di dichiarazioni esplicite (sarâhat) non si tiene conto di usi e consuetudini. Ad esempio, se nel contratto di vendita non è specificato con quale valuta pagare il prezzo, il pagamento viene effettuato con la valuta in circolazione nel paese; tuttavia, se è stato menzionato un mezzo di pagamento come l’oro o una valuta estera, si guarda a quanto specificato nel contratto, non all’usanza.
d) Che le usanze e i costumi non siano in contrasto con le prove più forti e concrete della religione.
Se una consuetudine o un’usanza contrasta con la disposizione di un versetto coranico o di un hadit, e non è possibile conciliarli, allora, per consenso unanime degli studiosi di diritto, tale consuetudine non è valida e non può essere presa come base per una sentenza. Gli studiosi di diritto islamico considerano il diritto basato su tali usanze e consuetudini come estraneo alla Sharia (fuori dal diritto islamico), mentre gli orientalisti hanno inteso questo aspetto più che il diritto consuetudinario in generale. (14) Pertanto, la relazione tra consuetudine e Sharia è un tema centrale che riguarda l’essenza del diritto consuetudinario.
Usanze e consuetudini in contrasto con altre prove:
Le usanze e i costumi che si praticano nella società musulmana sono in realtà basati su una prova religiosa.
(ad esempio, una sunna non tramandata)
Poiché si basa su fonti affidabili e la probabilità che sia in contrasto con prove vincolanti è ritenuta debole, è considerato una fonte (prova) giuridica forte, e la questione di quale sia preferibile in caso di confronto con un hadith singolo è stata dibattuta fin dai tempi dei primi imam giurisperiti.
La prima discussione riguarda le usanze e le pratiche degli abitanti di Medina.
(gli abitanti di Medina)
Intorno a questo si è sviluppato un dibattito, con Imam Malik che ha sostenuto che questa pratica fosse una prova convincente, e un gruppo di giuristi malikiti che ne hanno difeso la preferenza rispetto al hadith singolo (hadith-i vâhid). (15)
L’opinione secondo cui, trattandosi di una pratica di Medina che non si basa sull’interpretazione (ijtihad) ma sulla trasmissione (naql), si dovrebbe dare la preferenza all’hadith singolo (hadith-i vâhid), è stata adottata anche da altri giuristi come Abu Yusuf. Ibn Abidin, nel suo trattato “Nasr al-Arf”, ha fornito un’ottima sintesi del conflitto tra ‘adab e nass (tradizione e testo). (16)
Pertanto, la prova che entra in conflitto con la consuetudine e la tradizione è o un versetto coranico e un hadith, oppure un’interpretazione analogica (qiyas). I versetti coranici e gli hadith riguardano o un argomento specifico, oppure stabiliscono una regola generale.
a)
Se un versetto coranico o un hadit proibisce qualcosa, come ad esempio l’adulterio, il gioco d’azzardo, gli alcolici o l’usura, e si incontra con una consuetudine o una pratica che le considera lecite, la consuetudine non deve essere presa in considerazione; perché l’Islam è venuto per abolire definitivamente alcune consuetudini e comportamenti, mentre altri devono essere mantenuti così come sono o riformati. Gli esempi sopra citati appartengono alla categoria delle consuetudini e dei comportamenti aboliti definitivamente. L’unica eccezione è quando un testo sacro con una disposizione specifica si adatta a una consuetudine esistente al momento e che non si voleva cambiare, e poi questa consuetudine cambia. Mentre la maggior parte degli studiosi di diritto islamico sostiene che in questo caso si dovrebbe seguire il testo sacro e non la consuetudine cambiata, Abu Yusuf sostiene che si dovrebbe seguire la consuetudine.
Ad esempio, nei hadit (17) che illustrano come scambiare beni soggetti a interesse, si afferma che l’oro e l’argento devono essere scambiati con pesi uguali, mentre grano, orzo, datteri e sale devono essere scambiati con misure uguali (con bilancia). Secondo la comprensione di Abu Yusuf, i hadit si riferiscono al peso per i beni che all’epoca si usava pesare e alla misura per i beni che si usava misurare; ciò che conta è l’uguaglianza, se l’abitudine di misurare cambia e ciò che prima si misurava ora si pesa, non c’è alcun problema, l’uguaglianza viene garantita secondo la nuova abitudine; qui non si è agito contro l’essenza e lo scopo del testo, ma è cambiata solo la forma, che dipende dall’abitudine (18). Anche Muhammad Tahir ibn Ashur, un giurista tunisino del secolo scorso, la pensa come Abu Yusuf e spiega il suo pensiero con questi due esempi:
Il Profeta Maometto (pace e benedizioni su di lui) ha severamente proibito alle donne di depilarsi le sopracciglia, di allungarsi i capelli, di modellarsi i denti e di farsi tatuaggi sul corpo.
(19)
In realtà, queste non differiscono molto dagli altri tipi di abbellimento consentiti alle donne; tuttavia, il loro severo divieto è dovuto al fatto che, a quel tempo, questo tipo di abbellimento era una consuetudine delle donne dissolute e immorali. Allo stesso modo, in un altro versetto,
“O Profeta, comanda alle tue mogli, alle tue figlie e alle donne dei credenti di indossare il loro manto (il chador) quando escono; questo è più appropriato per essere riconosciute e non molestate. Allah è perdonatore e misericordioso.”
(20)
Così è stato ordinato. Qui, sia il fatto di indossare il cilbâb (l’abito esterno che copre tutto il corpo) sia il suo essere considerato un segno di castità si basano su usanze esistenti e praticate a quel tempo. Quando altri indumenti vengono utilizzati per coprire e riconoscere, sia il cilbâb che il suo essere considerato un simbolo di castità appartengono al passato. (21)
b)
Se norme generali (generiche) entrano in conflitto con una consuetudine relativa a un argomento specifico, entrambe le fonti mantengono validità grazie alla formula della تخصيص (tasḥīs). È generalmente accettato che, se la consuetudine riguarda il linguaggio, essa possa specificare (tasḥīs) la norma generale. Ad esempio, il significato lessicale della parola salāh (preghiera) è ampio; tuttavia, la salāh menzionata nelle fonti normative è intesa come la forma di preghiera che i musulmani avevano adottato come consuetudine al momento dell’arrivo di tali fonti; la consuetudine specifica (tasḥīs) la norma.
Molti esempi di questa precisazione si trovano nella maggior parte dei termini religiosi. Se l’usanza riguarda un’azione (pratica, applicazione) e non il linguaggio, si verifica innanzitutto se tale usanza era presente al momento della promulgazione del testo sacro. Secondo la maggior parte degli studiosi, tra cui Hanefiti e Malikiti, le usanze diffuse (generali) al momento della promulgazione del testo sacro ne precisano il significato. Sebbene gli hadit proibiscano la vendita di oggetti non esistenti o non ancora pronti, il contratto di commissione (istisna’) è considerato lecito, poiché questa usanza è diffusa e necessaria alle persone. Alle usanze pratiche (particolari) di una determinata regione o settore non è stata riconosciuta la facoltà di precisare il significato del testo sacro.
Le usanze che non esistevano al momento della promulgazione del testo sacro (nass) generalmente non possono derogare al nass; cioè, non sono valide in contrasto con il nass. L’eccezione a questa regola è rappresentata da usanze e consuetudini che eliminano la ragione (il fondamento) del nass che impone un divieto. Ad esempio, gli Hanafiti, sulla base di hadith pertinenti (22), non hanno ritenuto lecito un patto che non sia conforme alla natura del contratto e che avvantaggi una delle parti. La ragione di questa disposizione risiede nel fatto che tale patto potrebbe causare controversie. Tuttavia, se tale patto diventa una consuetudine generale, è ammesso e non invalida il contratto; poiché un patto diventato consuetudine non può essere oggetto di discussione o controversia (23).
c)
La preferenza delle usanze generali che contrastano con l’ijtihad e il qiyas è stata adottata dagli studiosi hanafiti e malikiti, e questa preferenza è stata considerata nell’ambito dello istihsan, senza richiedere che la usanza sia antica. Se un aspetto che non esisteva al momento dell’ijtihad e del qiyas diventa successivamente una usanza, sarà preferito al qiyas.
Funzione:
I costumi e le usanze hanno un’importanza e un’influenza significative nel diritto.
Le usanze e i costumi hanno il maggior impatto sulla nascita, la comprensione, l’applicazione e l’adattamento delle norme giuridiche alla vita sociale, attraverso la loro continua evoluzione.
a) L’usanza influenza la nascita e la formazione delle norme giuridiche.
Questa influenza vale sia per l’ijtihad (interpretazione giuridica) che per le norme giuridiche basate sulla rivelazione. Al-Shatibi afferma che è necessario che il legislatore (shari’) tenga conto delle usanze (fatti e leggi sociali).
ha basato la sua decisione sui seguenti motivi:
1)
L’usanza ha portato a comandare ciò che è sempre stato buono e a proibire ciò che è sempre stato cattivo, senza che ciò possa essere cambiato. Queste usanze vengono rispettate costantemente.
2)
Il rispetto delle consuetudini (leggi) che non sono stabilite dalla rivelazione, ma che sono in vigore nell’universo e nella vita sociale, è necessario sia perché esse costituiscono il fondamento dell’obbligo, sia perché si sa che il legislatore considera i loro interessi. Ad esempio, l’effetto deterrente della pena sul crimine è una realtà psicologica e sociale (legge, consuetudine); se il legislatore non la rispetta, l’obbligo e il diritto non possono sussistere. (24)
b)
L’usanza influenza la comprensione, l’interpretazione e l’applicazione del diritto e degli atti giuridici.
Nell’articolo 36 del Mecelle
“L’abitudine è inesorabile (viene imposta)”.
,
Nell’articolo 37.
“La consuetudine (il costume e la pratica) del popolo è un argomento (una prova) con cui è obbligatorio agire”.
nell’articolo 38
“Ciò che è di solito impossibile è come ciò che è impossibile in realtà.”
,
nell’articolo 40
“Con la forza dell’usanza, il significato letterale viene abbandonato (si abbandonano i significati lessicali delle parole e delle espressioni, prendendo invece i significati consuetudinari).”
Nell’articolo 43.
“Ciò che è consuetudinariamente noto è come se fosse stato pattuito (nei contratti, le clausole che sono diventate consuetudinarie sono considerate pattuite anche se non sono state pattuite verbalmente).”
,
nell’articolo 45
“La designazione per consuetudine è come la designazione per legge (ciò che è stabilito dalla consuetudine e dal costume è come ciò che è stabilito dalla parola).”
Le norme che vengono codificate in leggi sono espressioni potenti che rivelano questo tipo di influenza e funzione delle usanze e dei costumi.
c)
L’usanza e la consuetudine, insieme alle norme e ai principi giuridici ad esse correlati, cambiano e garantiscono la conformità del diritto alla vita sociale. Come diceva il giurista malichita al-Qarawi:
“Applicare le sentenze basate su usanze che sono cambiate è contrario al consenso degli studiosi e rappresenta ignoranza in materia di religione”.
La verità è che,
“Le norme e le disposizioni della Sharia (legge islamica) che sono state stabilite in base alla consuetudine, cambieranno in base alle nuove consuetudini quando queste cambieranno…”
(25) Articolo 39 della Mecelle
“Non si può negare che con il cambiamento dei tempi cambino anche le norme: è naturale che le norme basate sulla consuetudine cambino con il cambiare dei tempi.”
con queste parole ha espresso l’influenza citata dell’usanza. Gli studiosi di diritto hanno ripetutamente affermato che gran parte delle sentenze basate sull’ijtihad (interpretazione giuridica) dipendono dalle usanze e dai costumi dell’epoca in cui viveva l’ijtihadist, che se lo stesso ijtihadist avesse vissuto in altri contesti sociali, il suo ijtihad sarebbe stato inevitabilmente diverso, e che insistere su sentenze basate su vecchie usanze, mentre le usanze sono cambiate, porterebbe a difficoltà e problemi per il popolo, fornendo esempi di sentenze che sono cambiate nel corso della storia in base alle usanze:
Nei primi secoli, lo stato si faceva carico del sostentamento di coloro che svolgevano funzioni come l’insegnamento del Corano, l’ufficio di imam e di muezzin.
Successivamente, questi funzionari vennero privati del loro stipendio; se avessero svolto il loro lavoro, non sarebbero riusciti a sbarcare il lunario, e se avessero cercato di guadagnarsi da vivere, non sarebbero stati in grado di svolgere il loro compito. Per questo motivo –
Contrariamente alle opinioni dei giuristi hanafiti.
– Successivamente, i giuristi hanafiti hanno emesso una fatwa secondo cui è lecito ricevere un compenso anche per compiti che hanno la natura di un atto di culto.
Abu Hanifa, considerando la moralità prevalente al suo tempo, considerava idonei alla testimonianza coloro che non avevano precedenti (apparentemente moralmente integri), mentre Abu Yusuf e Muhammad, osservando un peggioramento della moralità nel loro tempo, ritennero necessaria l’indagine e la purificazione. Al tempo di Abu Hanifa, la coercizione poteva provenire solo dalle autorità statali, pertanto non si dava peso alla coercizione (ikrah) da parte di altri; successivamente, con l’insorgere dell’anarchia, la coercizione da parte di individui non ufficiali fu considerata valida. Sebbene, come regola generale, la pena fosse inflitta a chi commetteva direttamente il reato (mubashira), con l’aumento di delatori ingiusti e falsi, si ritenne opportuno punire anche questi ultimi. Poiché nel tempo le usanze e le esigenze cambiarono, nelle questioni relative alla compartecipazione agricola, alle fondazioni di beneficenza (waqf) e alle transazioni commerciali, si preferirono le interpretazioni di Abu Yusuf e Muhammad a quelle di Abu Hanifa.
Sebbene gli artigiani fossero considerati depositari per quanto riguarda i beni del cliente, a causa dei cambiamenti di morale e consuetudini, furono ritenuti responsabili di risarcire i beni del cliente perduti. Mentre secondo l’interpretazione hanafita era lecito che una ragazza maggiorenne fosse parte di un matrimonio e il matrimonio fosse considerato valido, a causa dell’abuso di questa interpretazione, si preferì l’interpretazione di Hasan b. Ziyad (m. 204/819) e questo contratto matrimoniale fu dichiarato nullo. Il fatto che il fango delle strade fosse considerato impuro, il contratto per entrare e lavarsi in un bagno turco senza specificare la durata e l’acqua da utilizzare, il contratto di eccezione, il contratto di bere acqua da pozzi senza specificare la quantità, ecc., sebbene fossero contratti nulli secondo l’analogia e le regole, furono considerati leciti e validi a causa dei cambiamenti di consuetudini e necessità. Le pratiche ottomane di mirî arâzî, icâreteyn e gedik sono esempi dello stesso tipo.
Il diritto consuetudinario all’interno del sistema giuridico islamico:
Gli orientalisti si occupano del diritto, in particolare di quello proveniente da epoche preislamiche e da regioni non islamiche, e di quello che è in contrasto con la sharia.
“diritto consuetudinario”
citano il nome, indicando come esempio il diritto applicato dai musulmani che vivono in regioni come l’Indonesia, la Malesia, l’India e il Nord Africa. (26) Alcuni storici del diritto e della cultura nel nostro paese, invece, prendono in considerazione soprattutto la pratica ottomana.
“che si oppone alla sharia e presenta un carattere laico”
alla legge
“legge consuetudinaria”
afferma.(27) Si intendono per tali le norme giuridiche che, pur provenendo dall’epoca pre-islamica di una determinata regione o essendo state importate da altri sistemi, non sono state approvate dagli esperti e non sono state incorporate nel sistema, in quanto ritenute contrarie e estranee ad esso.
“Deviazione dal sistema, sviluppo laico del diritto, rivoluzione…”
si può dire.
“Non si discute sulla terminologia”
Nonostante la regola, questo tipo di diritto non è incluso nel sistema giuridico islamico perché causerebbe confusione concettuale.
“diritto consuetudinario”
non si può.
Le informazioni sopra riportate portano alla conclusione che all’interno del sistema giuridico islamico sia possibile la formazione di un diritto consuetudinario, sia generale che regionale. È possibile parlare di due tipi di diritto consuetudinario: quello che nasce e si sviluppa all’interno del sistema, e quello che vi penetra e si integra con esso.
Il primo di questi è l’insieme delle norme e delle regole giuridiche basate sulla consuetudine e sulla tradizione, come abbiamo visto negli esempi sopra.
Il secondo è il diritto consuetudinario, che ha avuto origine e si è sviluppato come prassi di Medina ed è diventato un modello per altre regioni. La “prassi di Fas”, molto discussa, è un’estensione della prassi di Medina; tuttavia, mentre la prima si basa sulla caratteristica rappresentativa della Sunna degli abitanti di Medina, la seconda si basa su un’applicazione esemplare di un altro tipo e sulle esigenze e le usanze della regione.
Secondo le informazioni raccolte dagli storici del diritto della regione (28), le origini del diritto consuetudinario marocchino (el-amel el-fâsî) risalgono al diritto consuetudinario di Medina e dell’Andalusia. Con la diffusione della scuola malikita nell’Africa settentrionale, gli studiosi di diritto locali adottarono il principio del diritto consuetudinario di Medina, sviluppandolo ulteriormente e utilizzando le regole basate sulla consuetudine e sulla pratica, filtrate attraverso le fatwa e le sentenze giudiziarie degli studiosi di diritto della regione. Lo stesso pensiero e la stessa pratica si diffusero poi in Andalusia; quando l’Africa settentrionale passò sotto il controllo di governanti sciiti estremisti, i sunniti della regione si rivolsero al diritto consuetudinario andaluso, che era rimasto incontaminato, e lo applicarono nel loro paese. Secondo gli studiosi di diritto malikiti, il diritto consuetudinario marocchino si basa sulle necessità, sull’utilità pubblica (maslahat) e sulle consuetudini della regione. È naturale che, fintanto che queste necessità e consuetudini sono specifiche della regione, anche le norme che ad esse si riferiscono siano specifiche della regione.
Inoltre, affinché una regola di diritto consuetudinario sia valida, deve essere approvata da un giurista di cui si possa fidare per la sua competenza e moralità; altrimenti, non si applica la consuetudine, ma le disposizioni previste dal diritto teorico.
Si sa che sia nell’impero Selgiudico che in quello Ottomano, all’interno della legislazione amministrativa e giuridica, erano presenti dei codici. Tuttavia, non esistono prove né documenti sufficienti per affermare che questi codici siano stati emanati al di fuori della sharia, in base a un approccio e a una concezione laica.
Nel diritto islamico: consuetudine, principio di prevenzione del danno, interesse pubblico, criterio di bene pubblico.
Fonti di diritto come queste conferiscono ai giuristi e ai governanti ampi poteri nel campo della legislazione. Inoltre, ai governanti è stato affidato il compito di apportare le modifiche necessarie all’ordine pubblico nei settori della punizione e della politica religiosa.
I Selgiuchidi e gli Ottomani, nel promulgare i loro codici di legge, si sono basati sulle possibilità e sui poteri concessi loro dalla sharia, e generalmente hanno fatto approvare le loro decisioni e leggi dai mufti e dai sheikh-ul-Islam. (29)
Il diritto consuetudinario, nato e sviluppatosi in questo contesto e secondo questi principi, è senza dubbio una forma di diritto inclusa nel sistema giuridico islamico.
Nota a piè di pagina:
-
Al-Ma’ida: 7/199.
-
Ibn Arabi, Ahkâm, Beirut, s.d., vol. II, p. 823.
-
Nisâ: 4/26.
-
Per entrambi i termini: Zuhruf: 43/22.
-
Al-Baqara: 2/170.
-
Zuhruf: 43/24.
-
Nisâ: 2/26.
-
Nesâî, Zînet, 1.
-
Tirmidhi, Matrimonio, 1.
-
Keşfü’l-hafâ, vol. II, p. 188.
-
Ibn Hisham, Sīra, Il Cairo 1955, vol. 1, p. 188.
-
Neşru’l-arf, Mecmûa, Istanbul 1321, vol. II, p. 132 e seguenti.
-
Mecelle, art. 13.
-
I.A., voce “Usanza, consuetudine e diritto”, E.I., voce “Diritto consuetudinario”; Dr. Uceyl Câsim, “Gli orientalisti e le fonti della legislazione islamica”, Mecelletü’l-hukuk ve’ş-şerî’a, Kuwait, vol. II, n. VI, p. 77 e segg.
-
Mālik, Risālat al-Layṣ; Ibn Taymiyyah, Ṣiḥḥat usūl-i mazhab al-ahl al-Madīnah, Il Cairo, s.d., p. 21 e seg.; Qāḍī Iyāḍ, Tartīb al-madārīk, Rabat, 1965, vol. I, p. 52; Ibn Qayyim, al-Iʿlām, Il Cairo, 1955, vol. II, p. 361 e seg.
-
Ibn Abidin, Neşru’l-arf, p. 116 e seguenti.
-
Buhari, Buyû’, 74, 76; Muslim, Musâkât, 79-80.
-
Ibn Abidin, Neşr, p. 118.
-
Bukhari, Libas, 82-87; Muslim, Libas, 115-119).
-
Al-Ahzab 33/59.
-
Mekâsıdu’ş-şerî’ati’l-İslâmiyye, Tunisi, 1978, p. 91.
-
Si veda per le vendite condizionate. Buhari, Buyu’, 73; Tirmidhi, Buyu’, 19.
-
Ibn Abidin, Neşr, 121; Zerkâ, el-Medhal, Damasco, 1958, vol. II, p. 894 e seguenti.
-
al-Muwāfaqāt, Egitto, s.d., vol. II, p. 286 e segg.
-
el-İhkâm, Aleppo, 1967, pp. 231-232.
-
I.A., voci “Usanza” e “Costume”; E.İ., voce “Diritto consuetudinario”; Uceyl Câsim, agm.
-
Köprülü, İ.A., voce “Fıkıh”; Barkan, İ.A., voce “Kanunname”; İnalcık, İ.A., voce “Mahkeme”; “Introduzione al diritto ottomano”, SBF Dergisi, vol. 13, n. 2, pp. 102-126.
-
Muhammad ibn Hasan al-Hajjawi (m. 1376/1956), al-Fikr al-Sami fi Tarih al-Fiqh al-Islami, Medina, 1977, vol. II, pp. 405-411.
-
Per esempi, si veda İ.A., Süleyman I md.; TOEM, 1332/1916, cüz. 38, s. 74 e seguenti.
Con saluti e preghiere…
L’Islam attraverso le domande