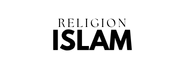– Perché, nel Patto di Medina, ebrei e cristiani scelsero il Profeta (pace e benedizioni su di lui) come loro capo?
– Perché non hanno protestato e hanno accettato?
– In fin dei conti, non ci credevano. Avrebbero potuto ribattere. Avrebbero potuto chiedere che il presidente fosse uno di loro. Ma hanno accettato. Perché?
Caro fratello/cara sorella,
Alle domande su questo argomento si può rispondere da diversi punti di vista:
1.
Quando il Profeta (pace e benedizioni su di lui) e i musulmani emigrarono a Medina, nella città vivevano tre tribù ebraiche. Queste tribù non vivevano tutte insieme; i loro insediamenti erano in diversi castelli e distanti l’uno dall’altro.
Per esempio
I Giudei di Beni Nadir
Si trovavano a tre chilometri da Medina, lungo la strada per La Mecca.
I figli di Kaynuka
abitavano invece nella zona di Âliye a Medina, in un luogo chiamato Cisr-i buhtan, all’interno di una fortezza/mura ben costruita.
Beni Kurayza
vivevano lì come tribù, al sicuro all’interno delle loro roccaforti.
2.
Come le tribù arabe degli Aus e dei Khazraj, che vivevano in quartieri diversi di Medina e che, pur essendo della stessa origine, si facevano guerra a vicenda, così avveniva anche tra le tribù ebraiche. Ad esempio, l’ultima guerra tra gli Aus e i Khazraj terminò cinque anni prima dell’emigrazione.
Battaglia di Buas
Era così. Questa guerra e questa ostilità si alternavano.
120 anni
era continuato.
In questa battaglia non erano coinvolti solo gli Aus e i Khazraj. Alleati degli Aus erano i Beni Nadir, una tribù ebraica, mentre gli alleati dei Khazraj, che si trovavano dalla parte opposta, erano altre due tribù ebraiche che vivevano a Medina: i Beni Kaynuka e i Beni Kurayza.
Le tribù di Banu Nadir e Banu Qurayza, pur essendo entrambe ebraiche, erano nemiche tra loro.
3.
Accadde nel secondo anno dell’Egira.
La spedizione di Kaynuka
durante questo periodo, il dissimulatore Abdullah ibn Ubay, appartenente alla tribù degli Hazrāj, aveva tentato di aiutare i figli di Kaynuka, che erano stati alleati – e lo erano ancora – nella battaglia di Buas.
Accadde nel quarto anno dell’Egira.
La spedizione contro i Beni Nadir
In quel periodo, Muhammad b. Maslama, appartenente alla tribù degli Aus, alleata dei Banu Nadir, era stato inviato come ambasciatore del Profeta.
Durante la battaglia di Banu Qurayza, avvenuta nel quinto anno dell’Egira, i loro alleati, gli Hazraj, intervennero per aiutarli. Fu addirittura inviato ad essi, dal Profeta (pace e benedizioni su di lui), Abu Lubaba di Aws, un compagno del Profeta, per proporre loro un accordo. Alla fine dell’assedio, i Banu Qurayza, costretti a fare pace con i musulmani, accettarono il giudizio di Sa’d ibn Mu’az di Aws, uno dei loro alleati, come arbitro.
4.
All’epoca, era consuetudine affidare la risoluzione delle controversie, la mediazione nelle guerre tribali e la soluzione di altri problemi legali a un arbitro competente e degno di fiducia. L’importante era che una persona affidabile, giusta e stimata risolvesse il problema.
Anche il Profeta, essendo una figura affidabile che aveva preso l’iniziativa nella stesura della Costituzione di Medina, fu accettato come arbitro da entrambe le parti. Se una delle parti avesse contestato, non avrebbe potuto essere l’arbitro. Ad esempio, poco prima, entrambe le parti avevano accettato come arbitro un musulmano, in relazione alla battaglia di Kurayza.
Sa’d ibn Muaz
Abbiamo parlato anche della sua attività di arbitro.
5.
Nel quinto punto, menzioneremo alcuni aspetti:
a)
In realtà, le spiegazioni che abbiamo fornito sopra sono quelle di Rasulullah (pace e benedizioni su di lui).
“Il Patto di Medina”
Questo dimostra perché, al momento della stesura, fu scelto un arbitro da tutte le parti. Infatti, gli Aws e i Khazraj erano nemici giurati. Anche le tribù ebraiche, alcune delle quali appoggiavano gli Aws e altre i Khazraj, erano reciprocamente nemiche e non costituivano un’unità.
b)
Anche tra le tribù giudaiche si erano create rivalità reciproche, che erano durate a lungo, in particolare a causa della guerra di Buas.
c)
Inoltre, è difficile che le tribù arabe e ebraiche che abbiamo menzionato, le quali sono reciprocamente ostili, possano fidarsi dell’arbitrato di una di esse.
d)
D’altra parte, non si è mai verificato alcun nemetismo o cattivo rapporto tra il Profeta (pace e benedizioni su di lui) e i musulmani di Quraysh che emigrarono con lui a Medina, e gli abitanti di Aws, Khazraj e gli ebrei, che firmarono insieme la Carta di Medina.
e)
Inoltre, è stato il Profeta Maometto (pace e benedizioni su di lui) a riunire le parti per la Carta di Medina, convincendole a difendere insieme Medina contro un attacco esterno. Egli era percepito come una persona affidabile, giusta e degna di fiducia. La carta redatta era a favore di tutti i cittadini di Medina, nel migliore interesse di tutti, ed era stata redatta liberamente dai ebrei e dai musulmani.
Inoltre, le persone possono stipulare contratti, accordi e partenariati commerciali, politici e basati su reciproci interessi anche con persone che non professano la loro stessa religione. A volte, firmano persino accordi e documenti con i loro nemici. Questo non costituisce un contratto o un accordo per cambiare religione. Ad esempio, un ebreo non cambia religione firmando un accordo o un contratto vantaggioso con un musulmano, così come un musulmano non cambia religione stipulando un accordo con un non musulmano.
Si noti che la proposta di un accordo per creare un’unità contro gli attacchi provenienti dall’esterno di Medina, contenuta nel documento, proviene da un musulmano e profeta, il Profeta Maometto (pace sia con lui).
In caso di controversia futura tra le parti in merito, sarà ancora il Profeta Maometto (pace e benedizioni su di lui) a fungere da arbitro.
Per le fonti relative a questo argomento, si veda:
– Sarıcık, Murat, L’invito del Profeta Maometto – Il periodo di Medina, Nesil Yayınları, Istanbul 2009, pp. 19-20, 81, 85-86, 140, 205-206, 209-210, 213.
– Per il documento di Medina, redatto nel primo anno dell’Egira, si veda Ibn Hisham, Abdu’l-Malik b. Hisham, Sirat al-Nabi, I-IV, Dar al-Fikr, Beirut 1981, II, 119-123.
– Muhammad Hamidullah, al-Wasā’iq al-Siyāsiyya, Dār al-Nafā’is, Beirut, 1987, pp. 57-73.
– Sarıcık, Il periodo di Medina, pp. 51-54.
Con saluti e preghiere…
L’Islam attraverso le domande